CONCETTI GENERALI
Lo studio delle condizioni che alterano il sonno di un individuo (in primo luogo l’insonnia) inizia con un’accurata anamnesi medica.
Il medico esamina le esperienze individuali della persona, nell’arco di tutta la giornata, non solo occupandosi di ciò che avviene durante la notte.
Devono essere portati alla luce eventuali alterazioni dell’umore, stanchezza, dolore muscolare, deficit di attenzione e ridotta concentrazione.
È fondamentale il diario del sonno, su cui il paziente deve annotare i dati su sonno e risveglio, eventuali pisolini, le attività svolte durante il giorno, l’assunzione di farmaci attivi sul sonno, gli orari e la quantità di alcol consumata, i pasti, il numero di risvegli durante la notte, per quanto tempo ritiene di aver dormito e il modo in cui percepisce il proprio stato d’animo e la vigilanza durante il giorno. Ancora più importante se il paziente giunge in studio preparato a queste domande.
Più della metà delle persone con disturbi del sonno ha sintomi riferibili a eccessiva sonnolenza diurna e soprattutto un’inconsapevole propensione a sonnecchiare.
Ma solo il 4-5% circa della popolazione dichiara di avere sonnolenza diurna.
Una percentuale molto più alta invece, circa il 20% della popolazione, lamenta insonnia o di non essere in grado di addormentarsi la notte. Inoltre, più del 60% delle persone che vanno dal medico di famiglia ha sofferto di insonnia e tra loro, almeno il 40% ha problemi di attenzione e memoria che si manifestano durante il giorno.
Ma solo il 16% di loro si cura.
Un milione di soggetti, in Italia, è poi affetto da un disturbo in grado di determinare insonnia, la sindrome delle gambe senza riposo.
LA VISITA DI MEDICINA DEL SONNO
Il medico di solito arriva a visitare pazienti che non sono migliorati o guariti spontaneamente dall’insonnia o in cui il disturbo si protrae da mesi (o anni).
Si parla di insonnia cronica per un disturbo che si presenta almeno tre notti a settimana per tre mesi o più; nella pratica clinica osserviamo le necessità di una popolazione attualmente molto provata dalla riduzione costante di ore di sonno, con situazioni ampiamente acuite dalla recente pandemia SARS Covid-19.
Adolescenti, adulti e anziani che giungono in ambulatorio, lamentano molto spesso problemi di insonnia iniziati da anni, avendo già provato senza successo o con risultati parzialmente soddisfacenti, rimedi e cure anche farmacologiche.
Non solo, quando chiedo i nomi dei farmaci o dei preparati assunti in precedenza, scopro che questi sono stati spesso dimenticati, o per inefficacia – disistima o perché impronunciabili.
Durante una visita per un disturbo del sonno, i medici sono soliti (o dovrebbero) informarsi su sintomi come la cefalea mattutina, la cataplessia (improvvisa perdita di tono muscolare innescata da forti emozioni come riso, collera, sorpresa o paura), la presenza di allucinazioni durante i periodi di sonnolenza, episodi di paralisi del sonno, episodi comunemente definiti di “sonnambulismo”.
Inoltre, è necessario intervistare i partner di letto del paziente, che possono fornire informazioni che una persona che dorme da sola non può percepire, come il russare, pause respiratorie più lunghe di dieci secondi, movimenti inusuali del corpo e sonnambulismo.
Sono importanti anche le domande sull’eventuale incontinenza urinaria notturna, su improvvisi episodi di difficoltà respiratoria, sul digrignare i denti (bruxismo) e parlare nel sonno, su tachicardie o aritmie notturne.
CONNOTAZIONI DELEGITTIMANTI IL SONNO
Nondimeno, accade frequentemente che al sonno venga data da troppo tempo una connotazione di “bene di lusso” o che si tenda a vederlo come un’attività secondaria, poco significativa o priva di valore rispetto ad altre funzioni del nostro sistema nervoso centrale.
Concezioni che spesso riducono il sonno a un semplice “periodo di inattività” o come una necessità fisiologica scontata e non degna di approfondimento o di considerazione.
Per molti il sonno è una “perdita di tempo”, un momento di “inefficienza”, un intervallo tra attività più importanti, una semplice “necessità biologica” senza implicazioni psicologiche o emotive, un comportamento “isolante”, una fuga dalle interazioni sociali o una rinuncia al coinvolgimento della vita di gruppo, lasciando immaginare che chi dorme “troppo” stia semplicemente evitando la realtà. O anche un momento della giornata che possiamo comprimere e ridurre (per lavoro o svago) senza alcuna conseguenza.
CENNI SULL’INSONNIA
L’insonnia può essere definita “lieve”, se una persona si addormenta durante un’attività sedentaria, come guardare la televisione; “moderata” se una persona scivola verso il sonno durante lo svolgimento di una qualsiasi attività fisica, come per esempio guidare; “severa”, se il sonno si manifesta durante un’attività fisica e intellettuale che richiede moderata attenzione, come parlare o mangiare.
Ovviamente, addormentarsi al volante dell’auto è molto più pericoloso che farlo durante una conversazione, ed è per questo che, generalmente, i medici prendono molto sul serio il sintomo “eccessiva sonnolenza diurna”. Ma addormentarsi mentre si parla, in realtà, indica un disturbo più grave, perché coinvolge in una sola volta molte più funzioni del nostro cervello.
LA PROCRASTINAZIONE DEL SONNO PER “VENDETTA”
In questo caso, ormai abbastanza diffuso, l’aspetto definito come insonnia per “vendetta” deriva dal desiderio di restare svegli nelle prime ore della notte per recuperare una sensazione di libertà compromessa durante il giorno, come se ci si volesse vendicare di tutto il tempo libero perso a causa dei propri impegni lavorativi o familiari.
Questa procrastinazione del sonno può manifestarsi nel ritardare l’andare a letto o nel procrastinare di addormentarsi dopo essere andati a letto.
Dopo una lunga giornata di lavoro o studio o di impegni di diversa natura, potrebbe risultare piacevole concedersi del tempo extra per rilassarsi prima di andare a letto.
Ma questa comprensibile esigenza potrebbe risultare più dannosa che utile quando, nel ritardare volontariamente e deliberatamente l’addormentamento, andiamo a comprimere le ore di sonno.
In definitiva, questa “vendetta” o desiderio di recuperare il tempo libero perso danneggia solo se stessi.
Nello specifico, le attività di procrastinazione spesso si manifestano in un maggiore utilizzo di dispositivi elettronici (cellulare, tablet, e-book, pc) o della televisione, che tra l’altro emettono luce blu in grado di disturbare ulteriormente il sonno.
Si riduce così il necessario riposo che consentirebbe di portare a termine le incombenze del giorno successivo in modo più efficiente, trascinando le persone in un altro ciclo di insonnia per vendetta il giorno seguente.
LA POLISONNOGRAFIA
La polisonnografia è la registrazione strumentale di una notte di sonno, una metodica che oggi è il principale strumento di diagnosi nel campo della medicina del sonno, caratterizzato dall’utilizzo di dispositivi modulari, in grado di indagare molteplici aspetti legati al sonno.
Un esame polisonnografico approfondito fornisce dati sul sonno, sulla sua struttura (fasi REM e fasi non-REM), sulla respirazione, sui livelli di ossigeno, sul ritmo cardiaco e l’elettrocardiogramma, sulla pressione arteriosa e sui movimenti degli arti inferiori o gli spostamenti (posizione) durante la notte.
Se un paziente afferma di avere troppo sonno durante il giorno, la polisonnografia è ben giustificata, dato il rischio elevato di avere apnee notturne o gambe senza riposo.
I medici possono utilizzare la polisonnografia anche per altri problemi che si sospetta siano legati al sonno o per i disturbi convulsivi o la narcolessia.
Per quanto riguarda l’insonnia cronica, la polisonnografia non è generalmente impiegata, se non quando si ipotizza che la causa principale sia un disturbo del sonno occulto, come le apnee notturne o il mioclono notturno (contrazioni muscolari involontarie) o per identificare e trattare al meglio la coesistenza di insonnia e patologie organiche.
Una polisonnografia completa implica il monitoraggio di una notte di sonno in regime di ricovero oppure (preferibilmente) a casa.
La diagnosi di insonnia è generalmente clinica, basata su un’accurata valutazione medica dei sintomi, delle abitudini di sonno e delle condizioni di salute generali.
Se necessario, possono essere utilizzati test diagnostici o esami strumentali come la polisonnografia, per escludere altre patologie. Se l’insonnia è persistente o grave, è importante consultare uno specialista, che potrà indirizzare il paziente verso una terapia adeguata, anche con modifiche dello stile di vita e comportamentali o talvolta con l’uso ragionato di farmaci.
Prof. Dott. Francesco Peverini
Specialista in Medicina Interna
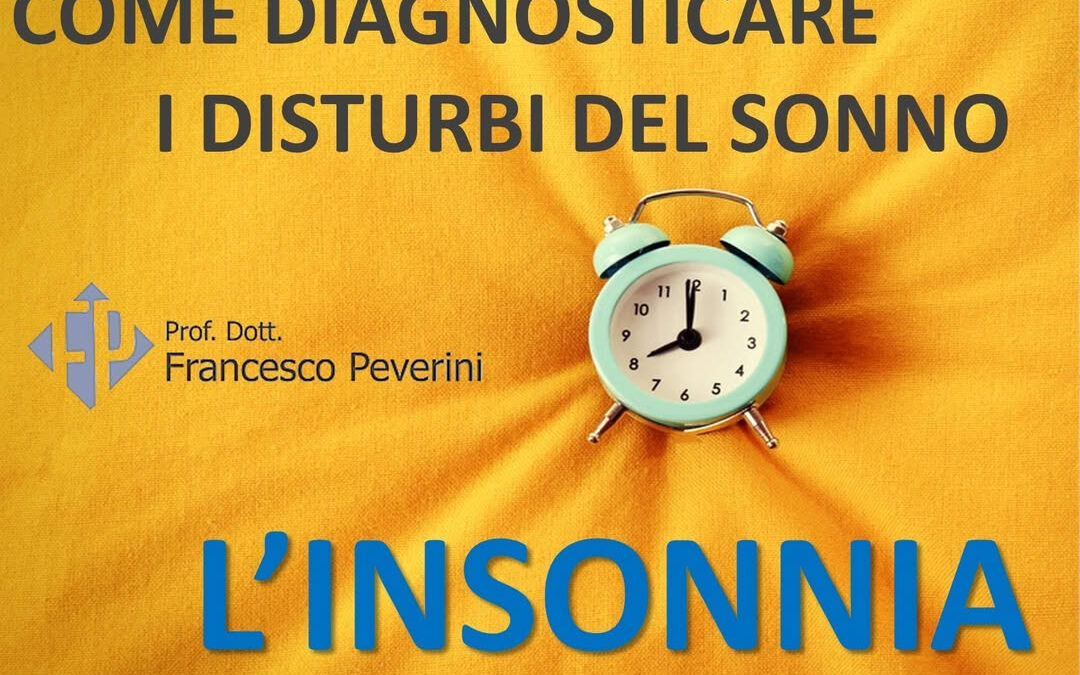
Commenti recenti